|
Con la sentenza n. 19155/2019 la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre separato nei cui confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo relativamente alle somme sostenute dalla ex coniuge per l’istruzione del figlio. il casoNel caso di specie gli sms erano stati utilizzati dalla madre del bimbo per provare l'adesione del padre all'iscrizione del minore all'asilo nido nonché l’intenzione di sostenere la metà della retta dovuta. Il padre, dunque, ricorrendo in Cassazione, ha sostenuto la carenza efficacia probatori degli sms, in quanto non idonei a provare sottoscrizione e numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti. La decisione della corteLa Corte ha, dunque, stabilito che:
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (fattispecie relativa alla valenza probatoria di alcuni sms). Il Garante per la protezione dei dati personali ha annunciato, con comunicato stampa del 2 luglio, la sua alleanza con l’AGCM e l’AGCOM. Scopo è disciplinare il fenomeno dei big data garantendo una politica efficace a livello pubblico. Big data: definizione Con il termine big data si indica quella raccolta di dati così ampia da richiedere tecnologie e metodi di analisi specifici per estrapolare, gestire e processare le informazioni. Nel 2000, Doug Laney, analista di settore, ha formulato la definizione delle tre V dei big data:
La cooperazione tra Autorità La necessità di cooperare con le altre autorità deriva dall’importanza che i dati hanno assunto per l’ottimizzazione di processi e decisioni, per l’innovazione e il corretto funzionamento dei mercati. A breve, il Garante Privacy renderà disponibile un documento elaborato a seguito delle audizioni svolti dalle tre Autorità. Le richieste al Governo e al Parlamento Tra le principali novità, si chiede al Governo e al Parlamento:
Sempre con maggior frequenza sentiamo parlare di blockchain. Ecco cosa significa, quali sono le garanzie che offre e qual è il legame tra questa tecnologia e gli smart contracts. Cos’è la blockchain La blockchain è una struttura dati condivisa e immutabile. Si tratta, in sostanza, di un registro in formato digitale alla cui base vi sono primitive crittografiche. Ciò che viene memorizzato sulla blockchain, una volta scritto, non può più essere modificato o eliminato. Tale sistema è nato nel settore finanziario ma, nel corso del tempo, evolvendo, è stato applicato ad altri ambiti. La blockchain, infatti, resa famosa dalle criptovalute, potrebbe ben rispondere alle crescenti esigenze di garanzia e richieste di tutela dei consumatori garantendo transazioni verificate e immuni da violazioni. Da tali caratteristiche sono attratti anche i grandi della produzione e della GDO globale tra cui Driscoll, Kroger, McCormick e Company, Tyson Foods e IBM. L’utilità della tecnologia nel settore alimentare La tecnologia in commento, se applicata al settore alimentare, ben potrebbe divenire uno strumento utile ad informare il consumatore circa la provenienza dell’alimento e ad agevolare le indagini sui cibi contaminati rendendo particolarmente veloci e sicure le informazioni lungo la filiera. Gli smart contracts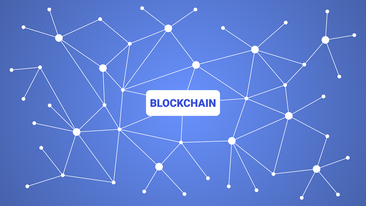 Dal punto di vista giuridico, uno degli elementi di maggior rilievo riconducibili alla blockchain è costituito dagli smart contracts. Già nel 1994 Nick Szabo definiva uno smart contract come: “un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto. Gli obiettivi generali sono: soddisfare le condizioni contrattuali comuni, ridurre al minimo le contestazioni sia dolose che accidentali, e ridurre al minimo la necessità di intermediari di fiducia. Obiettivi economici correlati includono la riduzione dei danni da frode, degli arbitrati, dei costi giudiziali e degli altri costi di transazione”. Si tratta, in sostanza, della trasposizione in codice di un contratto. Il sistema, in sostanza, si occupa di svolgere le dovute verifiche inerenti nel momento in cui si avverano le condizioni definite nel contratto. Anche tale tecnologia, però, non è esente da problemi. Ad esempio, come agirà il sistema in caso di mancata corrispondenza tra ciò che si intende e ciò che, invece, viene riportato? Occorrerà, dunque, semplificare i tecnicismi e curare con attenzione i meccanismi di traduzione dei contenuti del contratto. I vantaggi in ambito forense I vantaggi, in ambito forense, potrebbero essere diversi. Si pensi, in particolare, alla semplificazione della gestione dei procedimenti giudiziari derivante dalla facilità di acquisizione della data certa dell’esecuzione contrattuale, della successione temporale delle esecuzioni dei contratti della certezza di esecuzione della clausola da parte dei contraenti tramite validazione del blocco.
L'AGCM ha accertato che Apple e Samsung hanno violato gli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo.
L'attività istruttoria, infatti, ha accertato che alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari rilasciati dalle società hanno accelerato il processo di sostituzione degli stessi provocando gravi disfunzioni e riducendo in modo significativo le prestazioni. Leggi il comunicato Si segnala che è in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento al GDPR
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/09/04/205/sg/pdf In data 27 aprile 2016 è stato emanato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone fisiche e il trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati. Il regolamento, meglio noto come GDPR, si compone di 173 considerando e 99 articoli compresi in 88 pagine nella versione italiana. Con esso viene abrogata la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il regolamento sarà obbligatorio per tutte le imprese a partire dal 25 maggio 2018. I nostri Professionisti hanno redatto un vademecum in versione semplificata, epurata dagli elementi non necessari alle imprese ed arricchita però con specifici suggerimenti e con una guida pratica per l’attuazione delle norme, così consentendo al lettore una facile e rapida consultazione. Per ricevere l'indice e per informazioni scrivi a: ep@studiolegalepalumbieri.it Il marchio è regolarmente registrato ma difficilmente potrà essere utilizzato Chi non è inciampato, anche solo per sbaglio, nella vicenda dei fratelli Barbato?
Ebbene, trattasi di due imprenditori di Arzano, comune a nord di Napoli, che nel 2012 hanno registrato il marchio “Steve Jobs” e nel 2017 hanno vinto la battaglia legale contro Apple davanti all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Occorre, però, specificare un dettaglio: i giudici sono stati chiamati a decidere solo ed esclusivamente sulla possibilità di registrare il logo recante una “J” che, essendo una lettera, non può essere percepita come edibile con la conseguenza che il segno grafico sulla destra della stessa non può essere ritenuto un “morso” pur essendo pressoché identico a quello riportato sul celebre logo Apple. E per quanto concerne il nome? Un aspetto che, probabilmente è passato in secondo piano è che i fratelli hanno registrato un nome di persona, per giunta, notorio. Sotto questo profilo, infatti, vengono in rilievo due elementi. Il primo: ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del codice della proprietà intellettuale i nomi, se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi. Il secondo: la registrazione del nome proprio di una persona non deve lederne la fama, il credito o il decoro. Tutto ciò significa che i fratelli Barbato devono sperare che gli eredi di Steve Jobs non decidano di prendere in mano la situazione e agire a tutela del nome del fondatore della Apple. Come se ciò non bastasse, tuttavia, non può tacersi un altro aspetto di assoluta rilevanza: i fratelli hanno vinto una “battaglia” in sede amministrativa che potrebbe essere solo il primo di una serie di ostacoli all’utilizzo del marchio. Proprio questo elemento ci conduce ad una conclusione particolarmente grave: i fratelli Barbato potrebbero ritrovarsi nella impossibilità di utilizzare il marchio registrato. Ogni utilizzo, infatti, potrebbe dare adito ad una nuova azione legale. L’utilizzo per prodotti tecnologici, infatti, darebbe senza dubbio alla Apple una nuova occasione di opposizione con tanto di richiesta di pagamento di danni e spese legali. L’utilizzo, invece, per qualsiasi altro prodotto ben potrebbe ledere l’immagine di Steve Jobs dando adito ad iniziative a tutela della stessa da parte dei suoi eredi. Allora qual è l’unica possibile conclusione di questa faccenda? I fratelli non possono che sperare in una transazione con il colosso di Cupertino per monetizzare il marchio registrato. Qualsiasi altro utilizzo, stando alle informazioni in nostro possesso, potrebbe causare un notevole danno agli imprenditori napoletani. 18/1/2018 L’AGCM avvia procedimenti nei confronti di Apple e Samsung per obsolescenza programmataRead Now L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un comunicato di pochi minuti fa ha informato che, a seguito di segnalazioni provenienti dai consumatori e di un’attività preistruttoria svolta d’ufficio, ha deciso di avviare due distinti procedimenti nei confronti di Samsung ed Apple. La motivazione deriverebbe dalle presunte pratiche commerciali scorrette consistenti nello sfruttamento delle carenze di alcuni componenti volto a ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti al fine di indurre i consumatori ad acquistarne nuove versioni. Ai clienti, inoltre, sarebbero stati proposti aggiornamenti software senza segnalare le possibili conseguenze degli stessi e senza fornire informazioni sufficienti per mantenere un adeguato livello di prestazioni dei dispositivi.
Le violazioni, quindi, riguarderebbero gli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo. In assenza di norme specifiche bisogna ricorrere all’interpretazione delle regole esistenti Il mondo del diritto associato all’informatica, in questo periodo, si è spesso interrogato circa gli investimenti effettuati in criptovalute. Può sembrare strano parlare di investimenti in una valuta ma basti pensare che il bitcoin, che in questo preciso istante ha un valore di € 11.397, a gennaio 2017 aveva un valore di € 700. In molti, dunque, hanno utilizzato questa criptovaluta per generare delle plusvalenze.
Bitcoin e evasione fiscale Spesso si pensa alle criptovalute come uno strumento particolarmente idoneo all’evasione fiscale. E’ particolarmente diffusa, infatti, l’idea per la quale le transazioni effettuate tramite bitcoin non siano rintracciabili. Questa idea deriva, con tutta probabilità, dai primissimi utilizzi fatti del bitcoin e dalle conseguenze per i loro fondatori. Di questo, tuttavia, parleremo nel prossimo articolo in cui sposteremo il focus sulla configurabilità del reato di truffa aggravata. Lo scopo di questo post, infatti, è quello di rispondere a questa domanda: quali sono le regole applicabili ai guadagni effettuati grazie a criptovalute quali bitcoin, litecoin e ethereum? Il vuoto normativo In primo luogo è importante precisare che non esiste una norma ad hoc quindi tutto viene rimesso alla interpretazione delle norme esistenti. Al momento, infatti, l’unico elemento normativo degno di nota è rinvenibile nel d.lgs 90/2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione di valute virtuali e di prestatori di servizi relativi all’uso di queste. La definizione in commento, di cui all’art. 1 del d.lgs menzionato e attuativo della Direttiva UE 2015/859, però, non può essere d’aiuto nel rispondere alla nostra domanda. Un appunto: l’Italia è stata la prima ad adottare la IV Direttiva antiriciclaggio ma, a differenza degli altri paesi europei, non ha avviato una seria ricerca di soluzioni normative volte alla regolamentazione delle criptovalute. In linea generale, dunque, è opportuno specificare che, nel mondo finanziario, la tassazione riguarda la plusvalenza generata dalla cessione ad un prezzo maggiore a quello di acquisto. Quindi, per comprendere se tali norme siano applicabili alle criptovalute occorre individuare con precisione il campo d’azione delle stesse. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha paragonato, con la risoluzione 73E/2018, le criptovalute alle valute estere. In linea generale, quindi, gli scambi rilevanti con conseguenti guadagni di tipo speculativo, potrebbero generare plusvalenze da dichiarare nella sezione redditi diversi. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate sembra aver escluso tale ipotesi sostenendo che le operazioni in commento non possano mai essere considerate speculative. L’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Diversa interpretazione, invece, è stata data dalla CGEU con la sentenza C-264/2015. Questa, in particolare, ha escluso l’assimilazione alle valute estere avvicinando le criptovalute ai tradizionali sistemi di pagamento. Purtroppo anche l’interpretazione delle norme esistenti non aiuta a chiarire completamente la situazione pur dovendosi dare, per il momento, maggior rilievo alla interpretazione della Agenzia delle Entrate che, come detto, esclude la tassazione. Il consiglio, in ogni caso, è sempre quello di seguire le indicazioni di un esperto del settore che potrà valutare, caso per caso, il comportamento da adottare. La Corte di Giustizia ha deciso: "il servizio Uber non è soltanto un servizio d’intermediazione” Ormai in moltissimi utilizzano o hanno utilizzato il servizio Uber. In ogni caso, per chi non lo conoscesse ancora, è meglio precisare che questo si occupa di mettere in contatto i clienti con conducenti non professionisti. Ebbene, la Corte di Giustizia UE, interpellata da un giudice spagnolo a seguito di un ricorso proposto dell’associazione di conducenti di taxi denominata “Taxi Elite” di Barcellona, ha ritenuto che, nel caso di Uber, non trovino applicazioni né la libera prestazione dei servizi nell'Ue e neppure la direttiva sul commercio elettronico, che avrebbero svincolato il colosso americano dalla regolamentazione nazionale sui trasporti. In particolare, la Corte ha stabilito che tale servizio “non è soltanto un servizio d’intermediazione” ma “rientra nell’ambito dei servizi nel settore dei trasporti” e “gli Stati membri possono di conseguenza disciplinarne le condizioni di prestazione”. I conducenti, in particolare, accusavano Uber di “pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale”.
Ebbene, con la sentenza in commento, la Corte ha evidenziato che “un servizio d’intermediazione, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un’applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di ‘servizio nel settore dei trasporti’, ai sensi del diritto dell’Unione”. La Corte ha concluso che, sulla base del riparto delle competenze tra Unione Europea e Stati membri, spetta a questi disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi nel rispetto delle norme generali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Tribunale di Mantova ha deciso di impedire la pubblicazione di nuove foto e cancellare quelle già pubblicate Quante volte vediamo, sui social network e soprattutto su Facebook, genitori pubblicare foto dei loro figli? Si è sempre detto che queste foto possano, in qualche modo danneggiare il minore ma, in questi giorni, sul tema è intervenuta persino una sentenza del Tribunale di Mantova.
In particolare, stando a quanto sostenuto dal giudice «l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi». Il rischio starebbe nella «diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate». I pericoli, in effetti possono essere molti e la sentenza, per evitarli, ha stabilito che, da ora in poi, per pubblicare una foto sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. In particolare, il caso prende origine dalla richiesta presentata da un padre separato di due bambini (tre anni e mezzo la più grande, un anno e mezzo il più piccolo). L’uomo, infatti, aveva chiesto di rivedere le condizioni della separazione, con particolare riferimento all’affido condiviso e alla residenza dei bambini con la donna. Gli accordi, infatti, prevedevano il divieto per la moglie di pubblicare immagini e l’obbligo di rimuovere quelle già online. Dopo la pubblicazione di nuove foto, quindi, è intervenuto il giudice di Mantova. Questo, pur sostenendo che non sussistessero i presupporti per la revisione degli accordi richiesta dal padre, ha ritenuto che il comportamento della madre violasse la tutela dell’immagine (articolo 10 c.c.) e la tutela della riservatezza dei dati personali prevista nel Testo unico sulla privacy (decreto legislativo 196 del 2003) e nella Convenzione di New York. Questa, in particolare, stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione’ e che ‘il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti’”. Il Giudice Mauro Bernardi, inoltre, cita altre norme tra cui il regolamento europeo in materia di dati personali che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio e secondo il quale “l’immagine fotografica dei figli costituisce dato personale” e “la sua diffusione una interferenza nella vita privata”. Il Giudice, dunque, ha deciso di impedire ogni pubblicazione e rimuovere i contenuti già pubblicati. La Corte di Cassazione ha stabilito che le chat potranno essere prodotte in giudizio solo tramite lo smartphone. In questo articolo pubblicato qualche giorno fa vi abbiamo parlato della possibilità di utilizzare le chat di Whatsapp come prova in giudizio. Alla fine dell’articolo, in effetti, avevamo espresso qualche dubbio che, oggi, trova riscontro in una nuova sentenza della Corte di Cassazione.
Ebbene, la sentenza in questione riguarda le modalità di acquisizione di una conversazione Whatsapp come prova, nel caso specifico, in un processo penale. La Corte ha stabilito, con la sentenza numero 49016/2017 che l’unico modo idoneo è l’acquisizione anche del supporto telematico o figurativo. In sostanza, è necessario produrre in giudizio anche lo smartphone. L’osservazione della corte parte da un presupposto fondamentale: la registrazione delle conversazioni su Whatsapp è, ormai, rappresentazione di un fatto storico del quale è ovviamente possibile disporre a fini probatori. La prova in questione è una prova documentale e la sua produzione in giudizio è giustificata anche dall’art. 234 del codice di procedura penale. Tale articolo consente di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose attraverso varie fonti: fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo. La trascrizione, tuttavia, si limita a riprodurre il contenuto della prova documentale con la conseguenza che non è, da sola, sufficiente ma vi è ulteriormente necessità della produzione del supporto che la contiene. In sostanza, la sola stampa del pdf o dello screenshot di una conversazione Whatsapp non è sufficiente: questa semplicemente riproduce un contenuto che, però, per poter essere ritenuto valido, deve poter essere visionato anche sullo smartphone. A ben vedere, in effetti, la conversazione Whatsapp non può essere validamente dedotta in alcun altro modo. Se, ad esempio, nel caso di uno stato facebook pubblicato senza privacy possiamo sempre utilizzare un link specifico (anche nella sua versione cache), tanto non possiamo fare per le conversazioni Whatsapp. Questo causa una rilevante incertezza circa la effettiva valenza probatoria della chat che può essere superata solo ed esclusivamente tramite la produzione in giudizio dello stesso smartphone. Qualche giorno fa vi avevamo parlato della ritenuta di acconto del 21% sui canoni degli affitti turistici. Ebbene il Tar del Lazio, con ordinanza 5442/2017, ha respinto l’istanza di Airbnb che aveva chiesto di annullare il relativo provvedimento.
Il giudice, infatti, ha bocciato le argomentazioni dell’azienda per le seguenti motivazioni: 1) i denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali. In questo punto il TAR ha evidenziato che, in realtà, Airbnb potrebbe, solo in via eventuale, subire un danno dal versamento della ritenuta. Nessuna certezza, infatti, può ritenersi sussistente sul punto. 2) per quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell'azienda, considerato il suo volume d'affari in Italia, come indicato in ricorso. Nel secondo punto il Giudice ha evidenziato che, pur dovendo Airbnb sostenere delle spese per riorganizzare l’azienda al fine di adempiere all’obbligo di versamento della ritenuta, tali spese non possono in alcun modo pregiudicare la competitività dell’azienda, specie se si considera il suo volume di affari in Italia. 3) le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione. In questo punto il TAR ha sottolineato che le misure non possono essere ritenute discriminatorie: queste si applicano, infatti, solo a quegli intermediari che, in qualche modo intervengono nel pagamento del canone. 4) Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati, fermo restando che l'amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare l'opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria. Infine, il Giudice ha ammesso la possibilità, per l’amministrazione, di concedere ad Airbnb un periodo di tempo utile ad adeguarsi alla norma. La società, infatti, non lo aveva fatto precedentemente proprio in attesa della decisione qui commentata. depositata alla Camera una proposta di legge per mettere fine alla pratica di inviare bollette con una cadenza di 28 giorni ,Le tanto discusse bollette telefoniche a 28 giorni potrebbero essere al capolinea. E’ stata, infatti, depositata alla Camera una proposta di legge dalla deputata Alessia Morani (PD) “per mettere fine alla pratica, adottata da alcuni operatori di telefonia e pay tv, di inviare bollette con una cadenza di 28 giorni”.
La proposta di legge in questione, nelle parole della sua firmataria, "introduce l'obbligo della fatturazione dei servizi su base mensile; dispone un irrobustimento dei poteri di vigilanza da parte delle competenti Autorità; un aumento delle sanzioni da queste ultime comminabili e la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte degli operatori in caso di violazione dell'obbligo di cadenza mensile". La proposta, inoltre, limita "la possibilità di modificare, da parte delle aziende di comunicazione elettronica, in modo unilaterale le condizioni contrattuali". Tali modifiche "saranno ammesse solo con un giustificato motivo obiettivo". In aggiunta a quanto appena detto, la proposta prevede, con chiaro intento deterrente, un indennizzo forfettario, non inferiore ad euro 50, che l’operatore sanzionato è tenuto a corrispondere al consumatore interessato dalla illegittima fatturazione. Con la sentenza in questione la Suprema Corte ha dichiarato l’attendibilità del riconoscimento avvenuto tramite il social network di Mark Zuckerberg Uno degli argomenti più discussi circa il rapporto tra utilizzo dei social network e diritto è quello relativo alla possibilità di riconoscere un imputato tramite foto e informazioni presenti sul profilo online. Qual è, infatti, il limite tra privacy e esigenza di giustizia? Quando un soggetto può esere riconosciuto tramite un profilo social? E, in giuridichese, quali sono i limiti formali imposti dagli artt. 213 e 214 c.p.p.?
Ormai assistiamo da tempo alla contaminazione delle tradizionali pratiche investigative con le tecnologie moderne, tra cui proprio i social network. Vi avevamo, ad esempio, già parlato della possibilità di utilizzare il malware Trojan come strumento di indagine (qui: https://science.closeupengineering.it/malware-trojan-strumento-indagine/11227/) introdotto con la riforma Orlando. Quella novità, introdotta dal legislatore, viene, in questi giorni, affiancata da una decisione della Corte di Cassazione. In questo caso, però, al centro della sentenze c’è facebook e, in particolare, la possibilità di riconoscere un imputato tramite lo stesso social network. La sentenza in questione è la n. 45090/2017, con la quale la Suprema Corte ha accertato l’attendibilità del riconoscimento avvenuto tramite il social network di Mark Zuckerberg. Il ricorso in Cassazione, in particolare, era stato proposto proprio dall’imputato. Questo, condannato per concorso in rapina e porto d’armi, sosteneva non solo l’inattendibilità del riconoscimento attuato nelle modalità appena esposte ma, ulteriormente, riteneva che, in ogni caso, questo avrebbe dovuto essere seguito da un riconoscimento operato secondo le tradizionali modalità. Ebbene, la Corte, con la pronuncia sopra menzionata, ha rigettato il ricorso sostenendo la genuinità e attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, nonostante fosse avvenuto tramite Facebook. Anche le chat possono fare piena prova in giudizio Ormai i mezzi di comunicazione digitali costituiscono il principale strumento tramite il quale ci rapportiamo. Sono entrati nella nostra quotidianità e, anche giuridicamente, hanno assunto rilievo assoluto.
In verità, la controversia circa la possibilità di utilizzare le chat di Whatsapp in giudizio è durata ben poco e qualche giorno fa ne abbiamo avuto conferma. Andiamo per gradi partendo dagli sms. La Suprema Corte, infatti, più volte si è pronunciata sulla questione. E’ possibile citare, ad esempio, l’ultima sentenza a riguardo: la pronuncia numero 5510 del 6 marzo 2017, tramite la quale la Corte ha ritenuto valida, come prova del tradimento del marito, proprio gli sms inviati all’amante, decidendo per l’addebito della separazione a carico dello stesso. Dagli SMS a whatsapp il passo è breve. Il Tribunale di Ravenna, infatti, ha posto alla base della sentenza 231/2017 proprio le chat della nota app di messaggistica. Nella fattispecie, il Tribunale, ha condannato una donna alla restituzione all’ex amante dei soldi che questo le aveva prestato per comprare una auto. La controversia, in particolare, verteva sulla qualificazione di tale trasferimento di somme di denaro. Proprio i messaggi inviati tramite Whatsapp hanno risolto l’arcano: la donna, infatti, in chat si era impegnata a restituire tutte le somme in rate mensili di €200 e offrendo servizi di pulizia domestica.Il Giudice ha, quindi, ritenuto che le somme non fossero state corrisposte come atto di liberalità condannando, come detto, la donna alla restituzione. Qualche dubbio. Non tutto, però, è chiaro. Ad esempio: a differenza degli stati e delle immagini pubblicati – senza restrizioni di privacy – tramite il social network Facebook, le chat di whatsapp non hanno un link pubblico, non hanno una versione chache rinvenibile e non possono essere rintracciate se non tramite uno schreenshot o una stampa della conversazione in PDF. Dunque, chi può “garantire” sulla provenienza della chat? Chi può assicurarci che non sia stata modificata o, comunque, creata artificialmente? Difficile rispondere a queste domande. Occorre attendere nuove decisioni in merito. Tutti gli aggiornamenti sulla rubrica “Diritto 2.0” di Close-Up Engineering. La tassa dovrà essere pagata a partire dal 16 ottobre da tutti gli intermediari degli affitti turistici A partire dal 16 ottobre le piattaforme di intermediazione degli affitti turistici, tra cui airbnb, dovranno cominciare a pagare la tassa del 21% inserita nella “manovrina” di correzione dei conti pubblici da 3 miliardi di euro. La piattaforma airbnb, in qualità di intermediaria degli affitti turistici, avrà l’obbligo di trattenere e versare all’Erario le imposte dovute dai proprietari di casa. La tassa, per la precisione, dovrà essere corrisposta da tutte le 20mila agenzie iscritte alla Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (F.i.a.i.p.).
Come funziona la nuova tassa? In sostanza, viene stabilita una cedolare secca del 21%, introdotta nel 2011 per i contratti di locazione a canone libero 4+4, anche per le locazioni brevi (quelle con durata non superiore ai 30 giorni). Airbnb diventerà sostituto d’imposta: la ritenuta dovrà, infatti, essere gestita direttamente dagli intermediari. Il portale, quindi, tratterrà l’importo al momento del pagamento per poi versarlo all’Erario. Le proteste di Airbnb La protesta di Airbnb non si è fatta attendere e, per il tramite di Alessandro Tommasi (Airbnb Italy) ha subito evidenziato il danno che la nuova tassa recherà non solo al portale quanto anche al turismo italiano. Grazie ad Airbnb, sostiene Tommasi, sono giunti in Italia circa 5 milioni e 856 mila turisti con una permanenza media di 3,7 notti a soggiorno. Tali numeri potrebbero subire dei cali. La protesta di airbnb, tuttavia, non si ferma a queste motivazioni ma riguarda anche i tempi di attuazione della disposizione: la legge è operativa da giugno 2017 e il 12 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con le indicazioni per adottare il sistema della cedolare secca, definendo la scadenza per i primi versamenti al 17 luglio. Tempi tanto stretti da costringere gli operatori, secondo airbnb e altri soggetti interessati, a non rispettare la legge. Per questo motivo, a inizio agosto, è arrivata la proroga: i versamenti dovranno essere effettuati a partire dal 16 ottobre utilizzando il codice tributo 1919 tramite il modello F24. Il versamento verrà effettuato entro il giorno 16 di ogni mese per le locazioni del mese precedente. Airbnb, inoltre, al fine di garantire la più totale trasparenza nella gestione dei versamenti, dovrà inviare una certificazione annuale indicante tutti gli importi pagati. La decisione arriva al termine dell'istruttoria sulla riduzione dei periodi di rinnovo da 30 a 28 giorni Dal mese di settembre 2016 la Wind Telecomunicazioni S.p.a. aveva modificato il periodo di rinnovo delle proprie offerte da 30 giorni a 4 settimane comunicando che gli addebiti sarebbero avvenuti ogni 8 settimane anziché ogni 60 giorni. Inoltre, la stessa società aveva previsto, a carico di coloro che avessero esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 70, comma 4, cod. comm. elettr.:
a) l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto nel caso di offerte abbinate a prodotti in rateizzazione (telefono o tablet o mobile Wi-Fi); b) per le altre opzioni, il pagamento del corrispettivo previsto per il recupero del costo del modem e/o dell’apparato denominato “Google Chromecast” dovuti in caso di cessazione anticipata per la violazione dei vincoli di durata pari rispettivamente a 24 e 30 mesi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta e, a seguito dell'istruttoria, evidenziando la propria competenza a decidere della materia ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis del Codice del consumo, ha ritenuto che la Wind, abbia sfruttato la propria posizione di supremazia per esercitare una pressione idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio in relazione alla fruizione di servizi per i quali è stato richiesto, in corso di rapporto, un aumento di costo rispetto alla tariffa pattuita. L’Antitrust ha, quindi, irrogato a Wind una sanzione di 500.000 euro, per aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia fissa sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni. Qui il testo del provvedimento La pubblicità in rete mascherata da “lifestyle” potrebbe essere al capolinea fonte immagine: trend-online.com Navigando sui social network troviamo di frequente post di blogger e influencer pubblicati con finalità commerciali. Parliamo di pubblicità di ogni tipo, comprendente, ad esempio, capi di abbigliamento, ristoranti, hotels, car sharing, e persino prodotti alimentari.
Ebbene, nessuno dei blogger indica mai se si tratta di pubblicità o se, invece, è un autentico consiglio. Né, ovviamente, è dato sapere se l’attività viene “retribuita” o meno. Le condizioni di utilizzo di instagram che, in questi casi, è il social network maggiormente utilizzato, non prevedono alcuna regola: nessun hashtag, nessuna indicazione peculiare deve accompagnare il posting di contenuti per i quali è presumibile si riceva una retribuzione. Alcune domande, quindi, sorgono spontanee: Si tratta di attività conforme alle norme del nostro ordinamento? Chi tutela il consumatore? E come può, questi, distinguere i contenuti a scopo pubblicitario da quelli di puro “lifestyle”? Le risposte cominciano ad arrivare. Lo scorso 5 aprile per la prima volta un’autorità specializzata ha sanzionato una blogger per aver pubblicizzato un prodotto senza specificare il fine commerciale (tramite, ad esempio, l’hashtag #ad). Il 7 Dicembre 2016 la blogger inglese Sheikhbeauty pubblica la foto di una busta di the inglese con la seguente descrizione: “@flattummytea 20% off guys!!!! If you’ve been following me you’ll know i used this and I genuinely feel less bloated and a flatter tummy … oh yessss”. La blogger, oltre a taggare la marca del the in questione, pubblicizza uno sconto del 20%. Interviene -a seguito di ricorso- la Advertising Standards Authority (ASA) che impone alla blogger l’eliminazione del post. Ma non è l’unico caso. Autorità competenti e associazioni di settore sono di recente intervenute per cercare di individuare le regole tramite le quali i blogger possono pubblicizzare (su instagram e sugli altri social network) i prodotti più disparati. Tra queste, la statunitense FTC (Federal Trade Commission) e la australiana AANA (AustralianAssociation of National Advertisers). La domanda che tutti si pongono è: I blogger agiscono i maniera illecita? O meglio: E’ legittimo postare prodotti a scopo commerciale (e dietro compenso) simulando un “lifestyle” della webstar in questione? Quello che è cero è che il consumatore ha diritto di sapere se il post che sta guardando è pubblicitario o meno. A maggior ragione ove si consideri che, nella normalità e per tutti i mezzi di comunicazione -sia essa carta stampata, tv o radio- le finalità pubblicitarie vengono sempre ben evidenziate tramite immagini, scritte (anche sottotitoli) o suoni peculiari. L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato) al fine di verificare la legittimità dell’attività pubblicitaria “camuffata” sui social network. La base giuridica di tale esposto risiede nell’art. 22 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005) secondo il quale l’intento commerciale dev’essere esplicitamente indicato qualora non sia reso evidente dal contesto o, comunque, se è idoneo a indurre in errore il consumatore. L’esposto mira, con tutta evidenza, a sollecitare l’attività investigativa dell’Autorità Garante, sì da fornire risposte adeguate non solo sul rapporto interno tra produttore e blogger (compensi contrattuali), quanto anche -e soprattutto- sulla necessità di indicare in maniera esplicita e senza alcuna possibilità di fraintendimento il fine pubblicitario dell’attività. Nel frattempo, in attesa degli esiti della procedura AGCM, instagram è corsa ai ripari introducendo una nuova feature che permette di inserire un tag “Paid Partnership with” sia nelle storie che nei post pubblicati. In alternativa, l’utilizzo di hashtag che evidenzino lo scopo commerciale del post (come #ad, #advertisement, #pubblicità), sarebbe un’opportuna cautela per i blogger e, insieme alla feature appena introdotta, potrebbe rappresentare una -ancorché parziale- tutela del consumatore. UPDATE del 29.06: All'interno del DDL concorrenza, approvato alla Camera con 218 voti favorevoli, 124 contrari e 36 astenuti, è stato richiesto al governo di "valutare l'opportunità di un intervento a livello legislativo affinché l'attività dei web influencer sia regolata, permettendo ai consumatori di identificare in modo univoco quali interventi realizzati all'interno della rete internet costituiscano sponsorizzazione". UPDATE del 24.7 L'Autorità Antitrust ha diramato il seguente comunicato: "ANTITRUST SU INFLUENCER MARKETING: LA PUBBLICITA' DEVE ESSERE SEMPRE TRASPARENTE L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sta indagando sul fenomeno dell’influencer marketing nei social media. L’influencer marketing consiste nella diffusione su blog, vlog e social network (come Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Myspace) di foto, video e commenti da parte di “bloggers” e “influencers” (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di followers), che mostrano sostegno o approvazione (endorsement) per determinati brand, generando un effetto pubblicitario, ma senza palesare in modo chiaro e inequivocabile ai consumatori la finalità pubblicitaria della comunicazione. Tale fenomeno sta assumendo dimensioni crescenti in ragione della sua efficacia derivante dal fatto che gli influencer riescono a instaurare una relazione con i followers-consumatori, i quali percepiscono tali comunicazioni come consiglio derivante dall’esperienza personale e non come comunicazione pubblicitaria. Spesso, le immagini con brand in evidenza, postate sul profilo personale del personaggio, si alternano ad altre dove non compare alcun marchio, in un flusso di immagini che danno l’impressione di una narrazione privata della propria quotidianità. Le immagini, infatti, talvolta, rappresentano un ambiente domestico e sono realizzate con tecniche fotografiche non ricercate; altre volte, le tipologie di immagini, le pose dei personaggi e l’ambiente assumono lo stile di un set fotografico. L’evidenza data ai marchi può variare in intensità e modalità, in quanto le tipologie di post e personaggi si presentano molto eterogenee. In alcuni casi, i nomi dei brand sono citati negli hashtag dei post, in altri casi, sono invece in evidenza nell’immagine. Il post può essere accompagnato da commenti enfatici sul prodotto. Per sollecitare la massima trasparenza e chiarezza sull’eventuale contenuto pubblicitario dei post pubblicati, così come previsto dal Codice del Consumo, l’Autorità Antitrust, con la collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha inviato lettere di moral suasion ad alcuni dei principali influencer e alle società titolari dei marchi visualizzati senza l’indicazione evidente della possibile natura promozionale della comunicazione. Nelle proprie lettere, l’Autorità dopo aver ricordato che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, affinché l’intento commerciale di una comunicazione sia percepibile dal consumatore, ha evidenziato come il divieto di pubblicità occulta abbia portata generale e debba, dunque, essere applicato anche con riferimento alle comunicazioni diffuse tramite i social network, non potendo gli influencer lasciar credere di agire in modo spontaneo e disinteressato se, in realtà, stanno promuovendo un brand. L’Autorità ha pertanto individuato criteri generali di comportamento e ha chiesto di rendere chiaramente riconoscibile la finalità promozionale, ove sussistente, in relazione a tutti i contenuti diffusi mediante social media, attraverso l’inserimento di avvertenze, quali, a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, #prodottofornitoda; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio. Considerato che il fenomeno del marketing occulto è ritenuto particolarmente insidioso, in quanto è in grado di privare il consumatore delle naturali difese che si ergono in presenza di un dichiarato intento pubblicitario, l’Autorità sollecita tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel fenomeno a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo, fornendo adeguate indicazioni atte a rivelare la reale natura del messaggio, laddove esso derivi da un rapporto di committenza e abbia una finalità commerciale, ancorché basato sulla fornitura gratuita di prodotti. Roma, 24 luglio 2017" Il colosso accusato di aver violato la privacy degli utenti Whatsapp La Commissione UE, in qualità di Autorità Antitrust ha. deciso di irrogare una sanzione di 110 milioni di euro a Facebook per le informazioni fuorvianti fornite al momento dell’acquisto di Whatsapp.
Il social network di Zuckerberg, infatti, durante le operazioni di acquisizione (avvenute nel 2014 per un ammontare complessivo di 19 miiardi di dollariI), aveva, per ben due volte, ribadito alla Commissione l’impossibilità di collegare gli account Facebook a quelli Whatsapp: la prima volta in occasione della notifica dell’operazione, la seconda in risposta ad una specifica richiesta della Commissione. Tuttavia, nel 2016, con un aggiornamento dell’applicazione di messaggistica, la società di Zuckerberg aveva disposto il collegamento tra i numeri di telefono della chat e i profili del social network. La Commissione, quindi, ha oggi elevato la predetta sanzione che, va precisato, avrebbe potuto raggiungere l’1% del fatturato della società (che sarebbe corrisposto a circa 250 milioni di euro). La Commissione ha, invece, ritenuto di elevare una sanzione inferiore in considerazione anche dell’atteggiamento collaborativo tenuto da Facebook. Solo pochi giorni fa l’Autorità italiana (l’AGCM) aveva multato Whatsapp per 3 milioni di euro per aver indotto gli utenti a condividere i loro dati con l’account di Facebook. Il Tribunale di Frosinone ha ritenuto che il sito non violasse le norme in materia di diritto d’autore photo credit: www.tomshw.it Ormai non è difficile rintracciare online decine di servizi che, a fronte di un pagamento mensile, ci permettono di guardare film e ascoltare musica illimitatamente e con una qualità particolarmente alta.
Nonostante questo, sono ancora molti i siti che permettono lo streaming di film e musica in maniera gratuita e, spesso, con qualità particolarmente bassa. Ma questi siti sono contrari ad alcune delle norme del nostro ordinamento? Il Tribunale di Frosinone, esaminando l’attività di quei siti che fungono da aggregatori di link (e, cioè, che rimandano a film e musica in streaming provenienti da altri siti) in sede di opposizione a sanzione amministrativa, ha emanato una significativa ordinanza attinente alle possibili violazioni della legislazione in materia di diritto d’autore. Nei confronti del gestore del sito, infatti, era stata irrogata una sanzione amministrativa di € 546.528 a norma dell’art. 174-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d’Autore) per la violazione del diritto d’autore posto a protezione dei film ai quali i link rimandava. Su ricorso presentato dal gestore del sito, il Tribunale ha ritenuto non sussistente la violazione del diritto d’autore, enucleando le seguenti osservazioni. La prima riguarda le caratteristiche del servizio offerto dal sito. Nel caso specifico, infatti, il sito non ospitava direttamente i film in streaming ma si limitava ad aggregare link a film in streaming su altri siti. Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che la sola indicazione del link non fosse sufficiente ad integrare una condotta lesiva dei diritti dell’autore, non sussistendo una concreta e reale disponibilità dei file protetti, bensì dovendo l’utente di propria iniziativa scegliere se attivare il link. La seconda riguarda, invece, il guadagno ottenuto dal sito. L’art- 171-ter comma 2 lett. A-bis) della legge sopra menzionata prevede che, ai fini della irrogazione della sanzione prevista, sia necessario che la diffusione tra il pubblico dell’opera protetta abbia finalità di lucro. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, nella fattispecie, il sito non realizzasse un vero e proprio guadagno ma, più semplicemente, un “risparmio di spesa” rilevando, inoltre, come fosse impossibile fornire prova che i guadagni del sito derivassero dai singoli link. Il Tribunale, dunque, nella fattispecie, ha escluso la sussistenza di violazioni della legislazione in materia di diritto d’autore, e, quindi, la sanzionabilità dell’operato del gestore del sito. La sentenza che, ricordiamo, riguarda il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è la prima di questo genere in Italia ed Europa e sicuramente farà discutere a lungo, specie se si considera che, in data 20 aprile 2017, il Tribunale di Viterbo, in sede penale, ha interpretato le norme in maniera esattamente opposta condannando il gestore del portale “filmsenzalimiti.it” a otto mesi di reclusione e una multa di €1.720. Le motivazioni non sono ancora pervenute quindi seguiranno aggiornamenti sul tema. La presenza online di ogni impresa passa attraverso la registrazione di un nome a dominio efficace e la sua tutela Di Elio Palumbieri
La presenza online costituisce, oggi, una risorsa di straordinaria importanza per ogni impresa o professionista. Elemento fondamentale e punto di partenza per una buona presenza online è la registrazione di un nome a dominio facilmente memorizzabile e il più possibile corrispondente al proprio marchio. Il sistema dei nomi a dominio (Domain Name System, DNS) è utilizzato per la risoluzione di nomi degli host in indirizzi IP e viceversa. Un nome a dominio è costituito da un determinato numero di caratteri seguito da un’estensione. L’estensione indica la corrispondenza al registro nel quale viene iscritto il nome a dominio. Esistono tre tipi di registri, ognuno con proprie regole di registrazione: nazionali (es: .it, .de, .uk), regionali (es: .asia, .eu, .usa), generici (es: .com, .org, .info). Una volta effettuata la registrazione di un nome a domino è possibile effettuarne la cessione. Questa eventualità ha dato adito alla pratica del c.d. cybersquatting. Con il termine cybersquatting si indica la pratica di pirateria informatica, anche detta di domain squatting o domani grabbing, di chi registra abusivamente un dominio internet corrispondente a marchi commerciali o personaggi famosi al fine di lucrare sulla cessione ai soggetti interessati o al fine di indirizzare gli internauti verso il dominio abusivamente creato. Le tutele esperibili avverso tale pratica sono tre: quella riconducibile al principio del “first come, first served”, l’”uniform domain name dispute resolution policy” (UDRP) e la tutela dei marchi e dei segni distintivi. First come, first served Inizialmente l’unico principio applicabile in materia di registrazione dei nomi a dominio era quello del “first come, first served”. Tale principio, com’è intuibile dal nome, prevede che il legittimo titolare del nome a dominio sia colui che lo ha registrato per primo. Si tratta, quindi, di un criterio meramente cronologico che, è evidente, non garantisce alcuna tutela per il marchio eventualmente colpito dalla pratica di cybersquatting. l’UDRP A seguito della totale inerzia dei governi nazionali in materia è intervenuta una organizzazione privata: la Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICAAN). L’ICAAN, che oggi collabora con molti enti di registrazione, ha emanato nel 1999 il documento UDRP che mira a tracciare un metodo unico di risoluzione delle controversie inerenti i nomi a dominio. Tale sistema è stato, poi, adottato anche da molte autorità nazionali tra cui figura anche quella italiana. Per poter usufruire della tutela approntata dall’ICAAN è necessaria la presenza di alcuni requisiti:
La tutela di marchi e segni distintivi La giurisprudenza italiana ha fatto ricorso alla tutela di marchi e segni distintivi. Il principio di base prevede che chi ha registrato un marchio ha diritto di servirsene in modo esclusivo anche online tramite la registrazione del relativo nome a dominio. Dunque, il titolare di un nome a domino vittima di cybersquatting, può agire in giudizio al fine di richiedere il trasferimento del nome a dominio contestato, la sua cancellazione e, in ogni caso, il risarcimento del danno subito. Altra pratica di pirateria informatica, simile al cybersquatting e particolarmente diffusa, è quella di typosquatting. Con il termine typosquatting si indica la registrazione di nomi a dominio contenenti refusi rispetto al nome originale con lo scopo di sfruttare i possibili errori di digitazione di chi effettua delle ricerche online. Anche a tale pratica è possibile applicare le tutele di cui sopra. Cybersquatting e typosquatting: la tutela del nome a domi Di Elio Palumbieri
Il Senato ha approvato il provvedimento Orlando di riforma della giustizia penale conferendo delega al Governo anche sull’introduzione del malware Trojan come strumento di intercettazione. La norma è stata inserita anche a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (dep. 1 luglio 2016 n. 26889) che aveva ammesso l’utilizzabilità del malware anche nei luoghi di privata dimora, pure se non singolarmente individuati e se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica. Il DDL, in particolare, prevede la necessità di disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili. Il Senato ha anche introdotto i seguenti criteri da rispettare: 1) l’attivazione del microfono deve avvenire solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; 2) la registrazione audio deve essere avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell’articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l’ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 268 del medesimo codice; 3) l’attivazione del dispositivo deve sempre essere ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; 4) il trasferimento delle registrazioni deve essere effettuato soltanto verso il server della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; 5) devono essere utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, che tengano costantemente conto dell’evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia; 6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero può disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d’urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; 7) i risultati intercettativi così ottenuti possono essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale; 8) non possono essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede. |
Details
Archives
April 2022
|
Pagine |
© COPYRIGHT 2016. ALL RIGHTS RESERVED.
Avv. Alfonso Palumbieri
Partita I.V.A. 03827740725 Via Indipendenza, 22, 76121, Barletta (BT) |
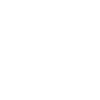























 RSS Feed
RSS Feed