|
Un protocollo così importante non trova precisa definizione nelle norme UE Il protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), nato nel campo della produzione di alimenti privi di difetti per astronauti, per avendo assunto una importanza assoluta per ogni azienda alimentare, non trova una specifica definizione nei regolamenti europei. Il Regolamento 852/2004, tuttavia, così come faceva anche la direttiva 93/43/CE, fa numerosi riferimenti a tali principi.
In particolare, l’art. 1 del regolamento afferma che tali principi dovrebbero informare una serie di procedure la cui applicazione generalizzata, affiancata alle regole di buona prassi igienica, è uno degli scopi del regolamento. L’art. 5, inoltre, stabilisce l’obbligo per gli OSA di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure aventi carattere permanente e basate su principi del sistema HACCP. L’art. 7 affida agli Stati membri il compito di promuovere l’elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e applicazione dei principi del sistema HACCP. Ebbene, come visto, i richiami al sistema sono diversi ma il funzionamento di questo non è delineato nel regolamento n. 852/04 il quale si limita, all’art. 5 a stabilire che “le modalità dettagliate di attuazione del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’art. 14 paragrafo 2” e, quindi, a rimettere all’attività legislativa della Commissione UE il compito di definire in modo più dettagliato l’adozione generalizzata del sistema HACCP. La Commissione, tuttavia, non ha ancora provveduto e, anzi, nei propri atti menziona l’HACCP facendo riferimento al reg. 852/2004. Da quanto detto deriva, quindi, che non esiste una vera e propria norma che descriva, in maniera precisa, il sistema HACCP. L’unico riferimento utile è la già menzionata direttiva del 1993 che, pur essendo ormai abrogata, forniva una definizione più chiara rispetto a quella contenuta nel reg. 852/04. Un ulteriore riferimento contenuto all’interno di questo regolamento, inoltre, è quello di cui al considerando n. 15. Questo, in particolare, prevede che i requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius. Il Codex, infatti, nell’altegato al Recommended International Code of PRactice General Principles of Food Hygiene, contiene il testo internazionalmente accettato delle linee guida utili all’applicazione dell’HACCP. I MOCA possono costituire un grave pericolo per la salute dei consumatori, per questo l’UE ne ha regolato la produzione Anche i materiali e gli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti (MOCA) devono essere sicuri. Sul tema tema è intervenuta l’Unione Europea con il Reg. 1935/2004.
L’imballaggio dei prodotti, infatti, assume la sua importanza in due fasi distinte: la conservazione del prodotto e la possibilità di ricondurre lo stesso al relativo produttore. L’imballaggio, dunque, assume rilevanza, ad esempio, nel caso di indicazione del lotto sullo stesso ovvero in caso di indicazione di determinati tipi di ingredienti o di ulteriori prescrizioni normative come il peso del tonno sgocciolato, la natura dell’olio adoperato ovvero la rispondenza alle prescrizioni normative dell’acqua minerale o di altre bevande. Non è, dunque, un caso se il nostro legislatore ha previsto che l’etichettatura dei MOCA debba contenere:
Il regolamento in questione, quindi, prevede specifici requisiti per materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti ovvero che si prevede che possano ragionevolmente entrare in contatto con gli alimenti. In particolare, l’art. 2 par. 2 lett. b regola i c.d. “materiali e oggetti attivi”, definendoli come quei materiali destinati a prolungare la conservabilità o a mantenere le condizioni del prodotto alimentare. In aggiunta a questi, l’art. 2 par. 2 lett. a definisce i “materiali e oggetti intelligenti” come quei materiali in grado di controllare le condizioni del prodotto imballato o del suo ambiente. Nel dettaglio, il regolamento prevede che entrambi i materiali non devono indurre in errore il consumatore. Infatti, i materiali attivi non devono in alcun modo modificare la composizione del prodotto e quelli intelligenti devono sempre essere adeguatamente etichettati per consentire al consumatore di identificarne le parte non commestibili. In conclusione è opportuno specificare che l’UE ha ulteriormente dettato specifiche norme per materie plastiche, ceramiche, pellicola di cellulosa rigenerata. Ecco come marchi e indicazioni d’origine e geografiche convivono sul mercato. Come noto, i marchi DOP e IGP costituiscono, per il nostro Paese, un importante patrimonio. L’Italia, infatti, detiene il primato mondiale di numero di prodotti DOP e IGP con 818 Indicazioni Geografiche registrate nel 2017 a livello europeo e un valore della produzione di 14,8 miliardi (il più alto di sempre) e 8,4 miliardi di valore dell’export. Lo scorso anno, ad esempio, si è registrata una crescita del 6%. Negli ultimi 10 anni, inoltre, il trend mostra una crescita continua del sistema DOP e IGP costituendo l’11% dell’industria alimentare del nostro paese e il 22% dell’export agroalimentare nazionale con un aumento nei 10 anni del valore del 70% e dell’export del 143%.
Un patrimonio da tutelare, quindi, ma quali sono le norme poste a tutela delle Indicazioni d’Origine e Geografiche? Ebbene, la tutela in commento viene in gioco soprattutto quando le DOP o IGP entrano in conflitto con marchi di impresa. In tal caso è possibile prevedere due tipi di scenario. Il primo è quello in cui la registrazione del marchio è successiva alla richiesta di registrazione di una DOP o di una IGP. In questo caso, l’art. 14 par. 1 del reg. 510/2006 prevede che la domanda di registrazione del marchio debba essere respinta e, in aggiunta, che eventuali marchi comunque registrati in violazione della disposizione in commento debbano essere annullati. Il secondo scenario è quello, invece, in cui la denominazione o l’indicazione confliggano con il marchio a queste preesistente. In tal caso l’art. 3 par. 4 prevede che non è consentito registrare una DOP o IGP che possa trarre in inganno i consumatori in quanto in conflitto con un marchio avente una propria notorietà e reputazione. Con questa disposizione, quindi, è stata riconosciuta una prevalenza del marchio notorio rispetto all’indicazione geografica o di origine. Il successivo art. 14 par. 2, tuttavia, prevede ulteriormente che un marchio possa continuare ad essere utilizzato quando è stato registrato prima della DOP/IGP. Tale norma, in sostanza, prevede la possibilità di coesistenza tra il marchio non notorio preesistente e l’indicazione geografica o di origine. Quanto appena detto evidenzia il carattere di specialità della norma di cui all’art. 3 par. 4, specie se si considera che lo stesso articolo specifica che la DOP/IGP deve essere tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto. Ecco le regole per utilizzare i claims sui propri prodotti alimentari Eliminare il glutine dalla propria dieta è, ovviamente, una priorità per chi soffre di celiachia. Ma, dove ci sono delle peculiari esigenze di dieta, solitamente, ci sono anche delle norme che vengono in soccorso fornendo definizioni e contesti di applicazione.
Ebbene, nel caso di alimenti gluten free è necessario fare riferimento al Regolamento 609/2013. Questo, in particolare, ha sostituito il concetto giuridico di “alimenti destinati ad una alimentazione particolare” (ADAP) con un elenco di tipi specifici di alimenti rivolti a persone con determinate esigenze dietetiche. Oggi, infatti, trovano specifica regolamentazione:
Tuttavia, tra gli alimenti più importanti destinati a consumatori con problematiche sanitarie e peculiari esigenze nutrizionali non possono non annoverarsi gli alimenti “gluten free”. I produttori di questi alimenti, che possono essere caratterizzati dal claim “senza glutine” o da claims analoghi hanno una doppia esigenza: devono, infatti, enfatizzare l’assenza di un determinato prodotto come in molti altri casi (zucchero, grassi, ecc) e dall’altro devono rimarcare l’assenza di una sostanza che potrebbe essere particolarmente pericolosa per alcuni consumatori. L’UE, sul punto, non solo ha aggiunto il claim “senza glutine” tra quelli ammessi ma ha anche previsto che le regole circa le nuove informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta fossero demandate ad un apposito regolamento della Commissione. Questa, quindi, ha adottato il Regolamento n. 828/2014. In base a questo, l’operatore che intende indicare l’assenza di glutine nel proprio prodotto dovrà seguire le seguenti prescrizioni:
Il marchio è regolarmente registrato ma difficilmente potrà essere utilizzato Chi non è inciampato, anche solo per sbaglio, nella vicenda dei fratelli Barbato?
Ebbene, trattasi di due imprenditori di Arzano, comune a nord di Napoli, che nel 2012 hanno registrato il marchio “Steve Jobs” e nel 2017 hanno vinto la battaglia legale contro Apple davanti all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Occorre, però, specificare un dettaglio: i giudici sono stati chiamati a decidere solo ed esclusivamente sulla possibilità di registrare il logo recante una “J” che, essendo una lettera, non può essere percepita come edibile con la conseguenza che il segno grafico sulla destra della stessa non può essere ritenuto un “morso” pur essendo pressoché identico a quello riportato sul celebre logo Apple. E per quanto concerne il nome? Un aspetto che, probabilmente è passato in secondo piano è che i fratelli hanno registrato un nome di persona, per giunta, notorio. Sotto questo profilo, infatti, vengono in rilievo due elementi. Il primo: ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del codice della proprietà intellettuale i nomi, se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi. Il secondo: la registrazione del nome proprio di una persona non deve lederne la fama, il credito o il decoro. Tutto ciò significa che i fratelli Barbato devono sperare che gli eredi di Steve Jobs non decidano di prendere in mano la situazione e agire a tutela del nome del fondatore della Apple. Come se ciò non bastasse, tuttavia, non può tacersi un altro aspetto di assoluta rilevanza: i fratelli hanno vinto una “battaglia” in sede amministrativa che potrebbe essere solo il primo di una serie di ostacoli all’utilizzo del marchio. Proprio questo elemento ci conduce ad una conclusione particolarmente grave: i fratelli Barbato potrebbero ritrovarsi nella impossibilità di utilizzare il marchio registrato. Ogni utilizzo, infatti, potrebbe dare adito ad una nuova azione legale. L’utilizzo per prodotti tecnologici, infatti, darebbe senza dubbio alla Apple una nuova occasione di opposizione con tanto di richiesta di pagamento di danni e spese legali. L’utilizzo, invece, per qualsiasi altro prodotto ben potrebbe ledere l’immagine di Steve Jobs dando adito ad iniziative a tutela della stessa da parte dei suoi eredi. Allora qual è l’unica possibile conclusione di questa faccenda? I fratelli non possono che sperare in una transazione con il colosso di Cupertino per monetizzare il marchio registrato. Qualsiasi altro utilizzo, stando alle informazioni in nostro possesso, potrebbe causare un notevole danno agli imprenditori napoletani. 18/1/2018 L’AGCM avvia procedimenti nei confronti di Apple e Samsung per obsolescenza programmataRead Now L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un comunicato di pochi minuti fa ha informato che, a seguito di segnalazioni provenienti dai consumatori e di un’attività preistruttoria svolta d’ufficio, ha deciso di avviare due distinti procedimenti nei confronti di Samsung ed Apple. La motivazione deriverebbe dalle presunte pratiche commerciali scorrette consistenti nello sfruttamento delle carenze di alcuni componenti volto a ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti al fine di indurre i consumatori ad acquistarne nuove versioni. Ai clienti, inoltre, sarebbero stati proposti aggiornamenti software senza segnalare le possibili conseguenze degli stessi e senza fornire informazioni sufficienti per mantenere un adeguato livello di prestazioni dei dispositivi.
Le violazioni, quindi, riguarderebbero gli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo. Diamo un'occhiata agli elementi giuridici legati ai ristoranti in casa Chi ama cucinare avrà pensato, almeno una volta nella vita, di aprire un ristorante. Bene, l’evoluzione dei mercati e, in particolare, la sharing economy hanno portato anche nel nostro paese l’idea dell’home restaurant (letteralmente: ristorante a casa).
Alla base di questo fenomeno c’è il desiderio del padrone di casa di cucinare per estranei per una sera: questi, infatti, somministra cibi e bevande a persone che non conosce e che, con tutta probabilità, non si conoscono tra loro. Spiegati questi aspetti è il momento di analizzare gli elementi giuridici posti alla base di questo tipo di attività. Partiamo da un appunto tutt’altro che irrilevante: in Italia la situazione è particolarmente complessa, infatti nel nostro ordinamento vi è ancora un vuoto normativo che ha portato a scontri particolarmente accesi. Da un lato i ristoratori si lamentano perché gli home restaurant, in sostanza, somministrano cibi e bevande senza le necessarie autorizzazioni e senza essere sottoposti ai normali controlli. Dall’altro lato chi intende sfruttare questa opportunità lamenta la mancanza di regole e, quindi, l’impossibilità di investire seriamente. In attesa delle nuove norme, non ci resta che fare chiarezza e vedere sui passaggi essenziali per avviare, oggi, un home restaurant:
16/1/2018 Commissione UE: ecco le novità in materia di etichettatura degli allergeni e QUIDRead Now Il Ministero della Salute ha da poco pubblicato sul suo sito due comunicazioni. Quella del 13 luglio 2017 e quella del 21 novembre 2017. La prima riguardante le modalità per informare i consumatori sulla presenza negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e la seconda sulle informazioni sulla quantità degli ingredienti.
La prima comunicazione, in particolare, definisce nuovi requisiti i materia di etichettatura degli allergeni. In particolare, questa stabilisce che gli ingredienti prodotti da cereali e contenenti glutine debbano essere evidenziati con una dichiarazione contenente un riferimento chiaro e specifico al cereale. La parola <<glutine>> potrà essere aggiunta volontariamente. Nel caso di alimenti per i quali non è richiesto l’elenco degli ingredienti ma che sono prodotti anche tramite l’utilizzo di prodotti che possono causare allergie o intolleranze, invece, è necessario evidenziare la presenza di allergeni. L’informazione al consumatore circa gli ingredienti può essere fornite tramite ogni tecnica di comunicazione: etichetta, altri materiali di accompagnamento, strumenti della tecnologia e comunicazione verbale. La seconda comunicazione, invece, ha lo scopo di fornire orientamenti per imprese e autorità nazionali circa l’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti. In particolare, l’obbligo di indicare il QUID, come noto, non si applica agli alimenti che comprendono un solo ingrediente. Il QUID, inoltre, non è obbligatorio nei casi previsti dall’allegato VIII del regolamento e nel caso degli alimenti non preimballati a meno che gli stati non abbiamo adottato specifiche misure nazionali. Il QUID è invece richiesto nel caso degli ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. Infine il QUID è richiesto quando il consumatore generalmente associa un ingrediente o una categoria di ingredienti alla denominazione dell’alimento. Inoltre, nella indicazione del QUID, a percentuale di carne presente, ad esempio, nel salame, deve essere indicata con un’indicazione basata sul peso della carne utilizzata per preparare 100g di salame. L’acqua aggiunta e gli ingredienti volatili devono essere indicati in funzione del loro peso nel prodotto finito. Tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui la quantità di acqua aggiunta non sia superiore al 5 % del prodotto finito. Il 2018 è appena cominciato ed è, quindi, il momento di presentare le principali novità normative nel settore alimentare.
Le principali rivoluzioni, infatti, saranno due: novel food e etichettatura. Novel Food: insetti a tavola A partire da questo mese sarà possibile commercializzare insetti commestibili nel nostro paese secondo le norme del Regolamento sui Novel Food. Questa novità potrebbe anche rappresentare un’interessante forma di investimento. Al momento, tuttavia, mancano le norme nazionali volte a definire i protocolli di allevamento e trasformazione quindi bisognerà ancora attendere. L’uso degli insetti a tavola è particolarmente diffuso in Africa, Asia e nelle Americhe. Al momento sono considerate commestibili circa 1.400 specie. Si tratta di una fonte proteica a basso costo e a basso impatto ambientale. Etichettatura Altro importante elemento di novità è quello riguardante l’etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare, da febbraio diventerà obbligatoria l’etichettatura di origine per pasta, riso, pomodoro e suoi derivati. In assenza di norme specifiche bisogna ricorrere all’interpretazione delle regole esistenti Il mondo del diritto associato all’informatica, in questo periodo, si è spesso interrogato circa gli investimenti effettuati in criptovalute. Può sembrare strano parlare di investimenti in una valuta ma basti pensare che il bitcoin, che in questo preciso istante ha un valore di € 11.397, a gennaio 2017 aveva un valore di € 700. In molti, dunque, hanno utilizzato questa criptovaluta per generare delle plusvalenze.
Bitcoin e evasione fiscale Spesso si pensa alle criptovalute come uno strumento particolarmente idoneo all’evasione fiscale. E’ particolarmente diffusa, infatti, l’idea per la quale le transazioni effettuate tramite bitcoin non siano rintracciabili. Questa idea deriva, con tutta probabilità, dai primissimi utilizzi fatti del bitcoin e dalle conseguenze per i loro fondatori. Di questo, tuttavia, parleremo nel prossimo articolo in cui sposteremo il focus sulla configurabilità del reato di truffa aggravata. Lo scopo di questo post, infatti, è quello di rispondere a questa domanda: quali sono le regole applicabili ai guadagni effettuati grazie a criptovalute quali bitcoin, litecoin e ethereum? Il vuoto normativo In primo luogo è importante precisare che non esiste una norma ad hoc quindi tutto viene rimesso alla interpretazione delle norme esistenti. Al momento, infatti, l’unico elemento normativo degno di nota è rinvenibile nel d.lgs 90/2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione di valute virtuali e di prestatori di servizi relativi all’uso di queste. La definizione in commento, di cui all’art. 1 del d.lgs menzionato e attuativo della Direttiva UE 2015/859, però, non può essere d’aiuto nel rispondere alla nostra domanda. Un appunto: l’Italia è stata la prima ad adottare la IV Direttiva antiriciclaggio ma, a differenza degli altri paesi europei, non ha avviato una seria ricerca di soluzioni normative volte alla regolamentazione delle criptovalute. In linea generale, dunque, è opportuno specificare che, nel mondo finanziario, la tassazione riguarda la plusvalenza generata dalla cessione ad un prezzo maggiore a quello di acquisto. Quindi, per comprendere se tali norme siano applicabili alle criptovalute occorre individuare con precisione il campo d’azione delle stesse. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha paragonato, con la risoluzione 73E/2018, le criptovalute alle valute estere. In linea generale, quindi, gli scambi rilevanti con conseguenti guadagni di tipo speculativo, potrebbero generare plusvalenze da dichiarare nella sezione redditi diversi. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate sembra aver escluso tale ipotesi sostenendo che le operazioni in commento non possano mai essere considerate speculative. L’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Diversa interpretazione, invece, è stata data dalla CGEU con la sentenza C-264/2015. Questa, in particolare, ha escluso l’assimilazione alle valute estere avvicinando le criptovalute ai tradizionali sistemi di pagamento. Purtroppo anche l’interpretazione delle norme esistenti non aiuta a chiarire completamente la situazione pur dovendosi dare, per il momento, maggior rilievo alla interpretazione della Agenzia delle Entrate che, come detto, esclude la tassazione. Il consiglio, in ogni caso, è sempre quello di seguire le indicazioni di un esperto del settore che potrà valutare, caso per caso, il comportamento da adottare. |
Details
Archives
April 2022
|
Pagine |
© COPYRIGHT 2016. ALL RIGHTS RESERVED.
Avv. Alfonso Palumbieri
Partita I.V.A. 03827740725 Via Indipendenza, 22, 76121, Barletta (BT) |
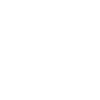






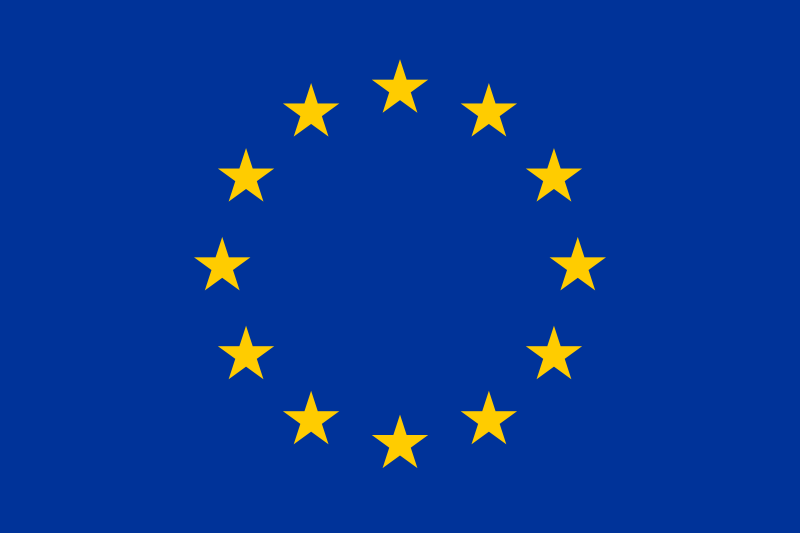


 RSS Feed
RSS Feed