|
L’OMS ha pubblicato le linee guida riguardanti l’uso degli antibiotici negli animali di allevamento sani.
Nel rapporto “Use of medically important antimicrobials in food-producing animals” l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di smettere di utilizzare antibiotici in modo regolare per promuovere la crescita e prevenire la malattia negli animali sani. Le raccomandazioni in questione, in particolare, sono sviluppate sulla base di una revisione pubblicata su The Lancet. Tale revisione, in particolare, ha rilevato che la limitazione dell’uso di antibiotici negli animali ha ridotto fino al 39% la presenza di batteri resistenti agli antibiotici presenti negli stessi animali. In sostanza, agli animali sani dovrebbero essere somministrati solo quegli antibiotici utili a prevenire le malattie in caso di diagnosi in altri animali dello stesso allevamento, gregge o popolazione di pesci. Tali antibiotici, inoltre, dovrebbero essere accuratamente selezionati con il fine di individuarne quelli più efficaci e con minor rischio per curare la specifica infezione o malattia. Stando a quanto emerso dal V Rapporto Agromafie elaborato da Euripses e dall'Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, il volume d'affari delle agromafie lo scorso anno è salito a 21,8 miliardi di euro con un aumento del 30% rispetto al 2015. Numeri impietosi e in continua crescita che necessitano di un approfondimento. Il consumatore, infatti, deve assumere consapevolezza di questo fenomeno per poter riconoscere, ad esempio, i prodotti e i ristoranti “sani” e distinguerli da quelli, invece, da evitare.
L’agroalimentare, infatti, è sempre stato un terreno privilegiato di investimento anche per la malavita che oggi, in questo settore, cerca un modo per riutilizzare i capitali derivanti da attività illecite. Cos’è l’agromafia? Si tratta di attività della criminalità organizzata che coinvolgono l’intera filiera agroalimentare. In questo campo, infatti, la mafia investe denaro ottenuto dalle attività illecite in settori quali ristorazione, turismo agricolo e grande distribuzione coprendo l’intero ciclo di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti alimentari. Le mafie, quindi, cercano nell’agroalimentare nuovi sbocchi di investimento. In particolare, due ambiti sono rilevanti sotto questo profilo: l’import-export di prodotti agroalimentari sottratti alle norme circa l’indicazione d’origine e tracciabilità (falso made in Italy) e la ristorazione. Il fenomeno del “falso made in Italy” consiste nella vendita di prodotti alimentari con etichetta o altri segni distintivi che richiamano una falsa origine italiana del prodotto. In sostanza: l’etichetta è italiana ma il prodotto no. Tale fenomeno, diffuso in tutto il mondo, è spesso riconducibile proprio alle agromafie. Queste etichettano come italiani alcuni prodotti di bassa qualità provenienti dall’estero e li immettono nel mercato italiano o estero a prezzi, ovviamente, particolarmente elevati. Il fenomeno, inutile dirlo, è molto pericoloso per i consumatori che, fidandosi dell’etichetta che, ad esempio, riporta denominazioni tipicamente italiane spesso associate al tricolore, credono di acquistare un prodotto genuino. A rimetterci, oltre al consumatore, sono anche le aziende italiane: un prodotto su due all’estero è un falso made in Italy per un giro d’affari che, complessivamente, nel 2015 ha raggiunto il valore di 36,8 miliardi di euro. Basti dire che, nei primi 7 mesi del 2015, la guardia di Finanza aveva sequestrato in Italia ben 160 tonnellate di cibi contraffatti. Almeno nella nostra nazione un modo per evitare di acquistare prodotti alimentari contraffatti è leggere con estrema attenzione l’etichetta del prodotto che state acquistando: all’interno, infatti, troverete tutte le informazioni utili ad evitare un simile errore. Per informazioni su come leggere l’etichetta, potete leggere un mio precedente articolo. Un esempio tipico, sotto questo profilo, è quello relativo al rinomato pomodoro San Marzano DOP: recentemente Nicholas Blechman, giornalista del New York Times, ha segnalato che negli Stati Uniti sono particolarmente diffuse confezioni di prodotti a base di pomodori di origine americana su cui, però, campeggia il nome “San Marzano”. La criminalità organizzata, tuttavia, è penetrata sempre maggiormente nell’economia legale investendo, tra gli altri, nel settore della ristorazione. Il business della ristorazione permette anche il riciclaggio di denaro derivante dalle attività illecite. A sottolinearlo è il Rapporto Agromafie sopra citato il quale ha evidenziato come tale sistema si attui tramite l’acquisizione e la gestione diretta e indiretta degli esercizi ristorativi. Stando a quanto riportato dal rapporto Coldiretti Euripses già nel 2015, nel nostro Paese i ristoranti nelle mani della criminalità organizzata erano almeno cinquemila. Insomma, non bisogna credere che il settore agroalimentare sia sempre “intonso”, privo di ogni contaminazione. Però due consigli possono essere utili. Ai consumatori: leggete le etichette fino nel dettaglio e se qualche informazione manca cercate anche online. Agli imprenditori: ponete la massima attenzione nell’etichettatura dei vostri prodotti anche sfruttando le informazioni facoltative e utilizzate in maniera efficace la comunicazione online e offline. Il Tribunale di Mantova ha deciso di impedire la pubblicazione di nuove foto e cancellare quelle già pubblicate Quante volte vediamo, sui social network e soprattutto su Facebook, genitori pubblicare foto dei loro figli? Si è sempre detto che queste foto possano, in qualche modo danneggiare il minore ma, in questi giorni, sul tema è intervenuta persino una sentenza del Tribunale di Mantova.
In particolare, stando a quanto sostenuto dal giudice «l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi». Il rischio starebbe nella «diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate». I pericoli, in effetti possono essere molti e la sentenza, per evitarli, ha stabilito che, da ora in poi, per pubblicare una foto sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. In particolare, il caso prende origine dalla richiesta presentata da un padre separato di due bambini (tre anni e mezzo la più grande, un anno e mezzo il più piccolo). L’uomo, infatti, aveva chiesto di rivedere le condizioni della separazione, con particolare riferimento all’affido condiviso e alla residenza dei bambini con la donna. Gli accordi, infatti, prevedevano il divieto per la moglie di pubblicare immagini e l’obbligo di rimuovere quelle già online. Dopo la pubblicazione di nuove foto, quindi, è intervenuto il giudice di Mantova. Questo, pur sostenendo che non sussistessero i presupporti per la revisione degli accordi richiesta dal padre, ha ritenuto che il comportamento della madre violasse la tutela dell’immagine (articolo 10 c.c.) e la tutela della riservatezza dei dati personali prevista nel Testo unico sulla privacy (decreto legislativo 196 del 2003) e nella Convenzione di New York. Questa, in particolare, stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione’ e che ‘il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti’”. Il Giudice Mauro Bernardi, inoltre, cita altre norme tra cui il regolamento europeo in materia di dati personali che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio e secondo il quale “l’immagine fotografica dei figli costituisce dato personale” e “la sua diffusione una interferenza nella vita privata”. Il Giudice, dunque, ha deciso di impedire ogni pubblicazione e rimuovere i contenuti già pubblicati. La Corte di Cassazione ha stabilito che le chat potranno essere prodotte in giudizio solo tramite lo smartphone. In questo articolo pubblicato qualche giorno fa vi abbiamo parlato della possibilità di utilizzare le chat di Whatsapp come prova in giudizio. Alla fine dell’articolo, in effetti, avevamo espresso qualche dubbio che, oggi, trova riscontro in una nuova sentenza della Corte di Cassazione.
Ebbene, la sentenza in questione riguarda le modalità di acquisizione di una conversazione Whatsapp come prova, nel caso specifico, in un processo penale. La Corte ha stabilito, con la sentenza numero 49016/2017 che l’unico modo idoneo è l’acquisizione anche del supporto telematico o figurativo. In sostanza, è necessario produrre in giudizio anche lo smartphone. L’osservazione della corte parte da un presupposto fondamentale: la registrazione delle conversazioni su Whatsapp è, ormai, rappresentazione di un fatto storico del quale è ovviamente possibile disporre a fini probatori. La prova in questione è una prova documentale e la sua produzione in giudizio è giustificata anche dall’art. 234 del codice di procedura penale. Tale articolo consente di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose attraverso varie fonti: fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo. La trascrizione, tuttavia, si limita a riprodurre il contenuto della prova documentale con la conseguenza che non è, da sola, sufficiente ma vi è ulteriormente necessità della produzione del supporto che la contiene. In sostanza, la sola stampa del pdf o dello screenshot di una conversazione Whatsapp non è sufficiente: questa semplicemente riproduce un contenuto che, però, per poter essere ritenuto valido, deve poter essere visionato anche sullo smartphone. A ben vedere, in effetti, la conversazione Whatsapp non può essere validamente dedotta in alcun altro modo. Se, ad esempio, nel caso di uno stato facebook pubblicato senza privacy possiamo sempre utilizzare un link specifico (anche nella sua versione cache), tanto non possiamo fare per le conversazioni Whatsapp. Questo causa una rilevante incertezza circa la effettiva valenza probatoria della chat che può essere superata solo ed esclusivamente tramite la produzione in giudizio dello stesso smartphone. |
Details
Archives
April 2022
|
Pagine |
© COPYRIGHT 2016. ALL RIGHTS RESERVED.
Avv. Alfonso Palumbieri
Partita I.V.A. 03827740725 Via Indipendenza, 22, 76121, Barletta (BT) |
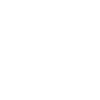




 RSS Feed
RSS Feed